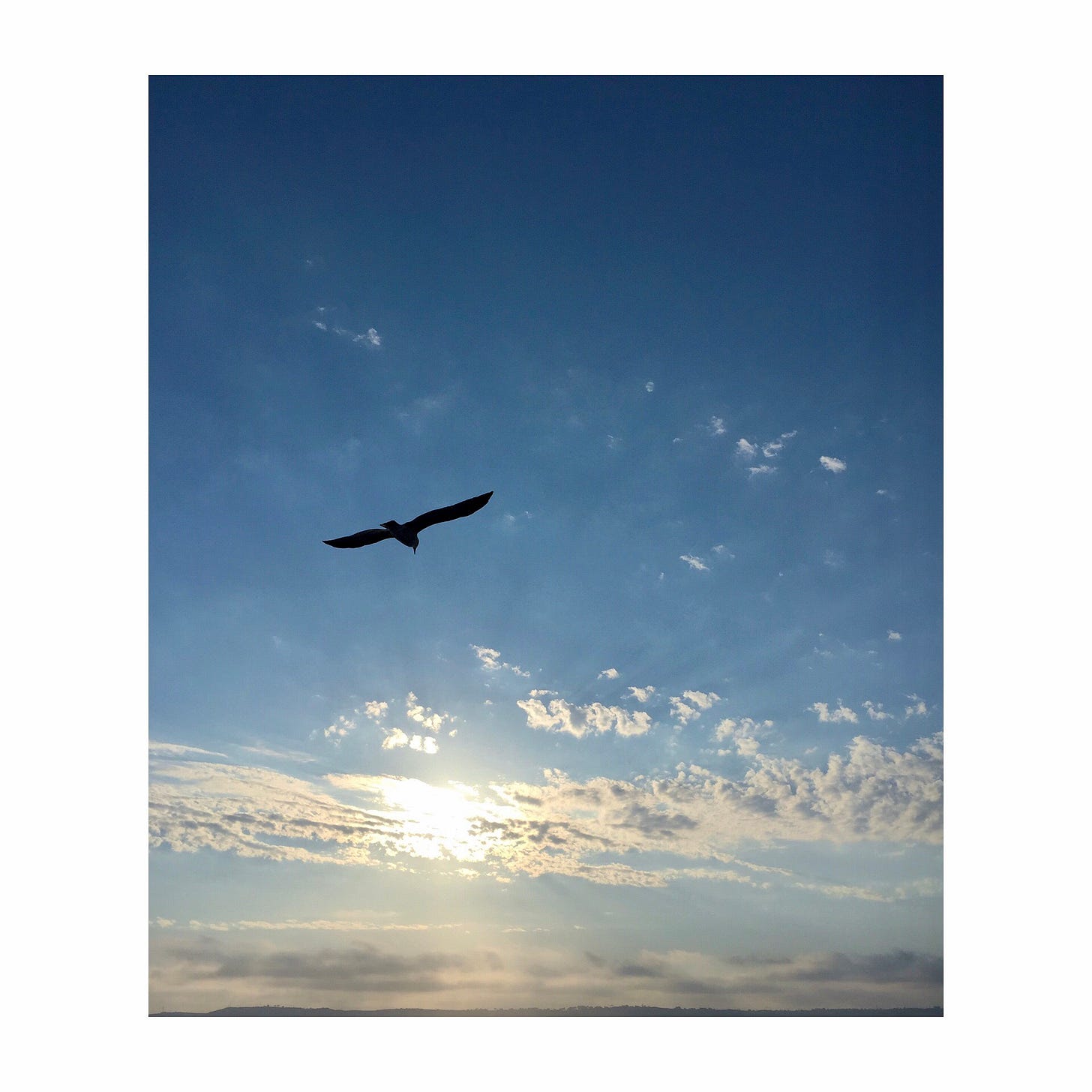Sulla strada
“Nel tuo petto sono le stelle del destino.”
(Carl Gustav Jung)
Alcuni anni dopo.
La porta automatica fa incessanti movimenti a destra e sinistra, aprendosi e chiudendosi a scatti infiniti. E la gente entra ed esce a mazzi, così come le folate di aria fresca dei primi giorni di autunno, le speranze e i sogni infranti.
È in momenti come questi che mi pento di non aver mai iniziato a fumare, lì in piedi fuori dall’ingresso di questo grande edificio grigio e brutto, che resta grigio e brutto anche se la vita che lo circonda appare leggera e piacevole e il semplice fatto di vivere crea soddisfazione, oltre la presenza insignificante di questo palazzo alto.
Guardo l’ora sul display del telefono. Devo andare o farò tardi. Non faccio mai tardi. Ma è la ferma incapacità di darmi coraggio a farmi aspettare un momento oltre. L’ultima volta che sono stata qui era più di sei mesi fa, avevamo parcheggiato in una via dietro quel negozio di frutta e siamo entrati insieme, uno di fianco all’altra, poi quando siamo usciti siamo andati a bere il caffè e mangiare un biscotto dal sapore anemico in quell’anonimo bar dall’odore vecchio. O forse era solo l’odore insopportabile delle cose che finiscono mentre tutto il resto procede il suo scorrere incessante. Il mercoledì che segue il martedì, il lunedì che viene dopo la domenica. Oggi è lunedì e oggi sono esattamente otto mesi che non sento più il suono della sua voce davanti a una tazza di caffè.
Rimetto il telefono il tasca, guardo l’asfalto ruvido come se avessi buttato una sigaretta ancora accesa e varco l’ingresso dell’ospedale.
Buongiorno.
Buongiorno.
È qui per una visita?
No, ho una appuntamento con la dottoressa Guardia.
Prego, in fondo al corridoio a sinistra, secondo piano, stanza 10.
Sì, grazie, conosco la strada.
Sento nella mia voce un’esitazione metallica, come se quella frase fosse uscita dal mio corpo contro la mia volontà. In questi mesi di sconfinata assenza, ho notato che in certe circostanze mantenermi calma è una vera e propria sfida. Una canzone uscita dalla radio senza che te la aspetti, un “come stai” chiesto girando l’angolo, la voce di uno sconosciuto che ti indica la strada di un reparto di ospedale. È lì, che sta l’inciampo: in quella miriade di ricordi nascosti che non ti sei mai accorto di essere importanti o forse neanche di esistere. Ma dopo la morte, la perdita e la mancanza, tutto diventa importante, anche i corridoi di un ospedale. E dopo che muori dentro, ti accorgi di sapere e vedere tutto.
La sala d’attesa del reparto di oncologia è come l’ho lasciata mesi fa. Le seggioline di plastica blu, il pavimento con le piastrelle bianche, la libreria con gli stessi libri che nessuno avrà sfogliato nell’attesa di essere chiamato e quella pianta grassa che nessuno avrà bagnato. Anche la voce all’altoparlante sembra la stessa con quel suono gracchiante che va e viene.
Paziente n. 853 in stanza 5.
Mi siedo su una sedia a caso, lontana dal caos di quel silenzio che è l’attesa. Le guardo quelle persone che potevo essere io, e che in effetti sono stata anche io, e intravedo nei loro occhi quella remota speranza dentro un attimo di stanchezza e attesa infinita. Non lo notano neanche, il contorno che li circonda. Fluttuano del vuoto denso. Per me, invece, che l’attesa ha oltrepassato la fine, tutto ha il sapore fitto dei ricordi, qualsiasi dettaglio, e ogni dettaglio è pregno di tensione e sensi di colpa. Avrei dovuto tenergli la mano più forte mentre aspettavamo il nostro turno ogni lunedì.
Merda, Pan Pan, ho lasciato a casa gli esiti degli esami del sangue.
Li ho presi io, Jacques. Tranquillo.
I suoi occhi sono ovunque, penetrano l’aria e i pori della mia mente. Così, per non sprofondare dentro quel senso di nausea sconfinata, indosso i grandi occhiali da sole e inizio a piangere. Lo faccio sempre, tutti i giorni. È esattamente 242 giorni che piango ogni giorno. Li ho contati l’altro giorno. D’altronde, essere immuni richiede una forza che in questo momento non so dove sia, nascosta sotto cumuli di nebbia fragile. Richiede di imparare a vivere sopra il dolore, la mancanza, il trauma, la solitudine, tutte cose troppo ingombranti per lo spazio vuoto che è la mia vita ora. E nonostante il lavoro e la moltitudine di possibilità, il silenzio mi resta addosso ovunque.
È occupato?
No, prego.
E sposto la borsa per liberare il posto accanto a me.
Il signore sulla sessantina si siede con le gambe composte e controlla la cartellina trasparente con dentro tutti gli esami e accende un’applicazione di news dal telefono. Sa che l’attesa è lunga.
Intanto, la luna fuori dalla finestra e oltre le nubi ondulate si intravede tonda e lontana. Chissà come si sentirà, lassù sopra il sereno.
Mi piacerebbe imparare a scrivere della luna, il passare dei giorni e il rumore della morte. Dovrei scrivere un romanzo sul silenzio. Dovresti scrivere un libro, sai? Me lo diceva sempre.
Tu sei la ragazza di Stefano, vero?
La voce di un ragazzo dai capelli rossi mi riporta sulla terra.
Sì, ci conosciamo?
No, non direttamente. Ma conosco Stefano perché spesso avevamo le visite lo stesso giorno e ogni tanto ci era capito di parlare. Qualche volta mi ha parlato anche di te, mi ricordo che mi ha detto che lavori nella moda e da come raccontava di te ti ho sempre immaginata come una persona importante. Vi ho visto qualche volta qui ad aspettare insieme, ora però è tanto che non lo vedo, è dentro con la dottoressa Guardia per la visita?
Ascolto quella voce e quella domanda come se fossi andata a schiantarmi contro un muro di cemento nell’oscurità. E nell’impatto, l’istante vacilla, inclinando l’asse terrestre delle certezze.
Scusa, ti chiami?
Andrea.
Ciao, Andrea. Sono Charlotte. Oggi sono qui da sola. Stefano è venuto a mancare a febbraio, mi spiace.
Vedo i suoi occhi aprirsi e poi spegnersi lentamente, come se il mondo e le parole per un breve attimo inconsistente si fossero esaurite.
Gli sorrido per riportarlo a galla.
Perdonami, Charlotte. Scusa se sono stato indiscreto. Lo vedevo sempre sorridente e positivo, ero convinto che stesse meglio.
Già, eravamo convinti anche noi.
Paziente n. 487 in stanza 12.
Il peso piatto dell’altoparlante rende in un istante il mondo più lieve.
Ci mettiamo a chiacchierare, di questi mesi, dei suoi ultimi mesi, dei miei nuovi giorni, di ospedali, visite, dell’età media sempre più bassa, conosco un ragazzo che è malato da cinque anni, alla mia collega di trentaquattro anni glielo hanno appena diagnosticato. Conversazioni per ingannare il tempo e la morte.
Andrea se ne va, entrando nella sua stanza 10 e io torno ad aspettare, di nuovo sola.
Apro il libro che mi sono portata ma non riesco a concentrarmi, accendo il telefono ma non riesco a distrarmi, come se fossi circondata da presenze inesistenti.
Guardo l’orologio. Inizia a farsi tardi, così riapro la email per controllare di non aver sbagliato giorno, ora, vita.
“Ti aspetto lunedì alle 15.30, stanza 10”.
Sono quasi le 17.00 e inizio a essere stanca, della giornata, di aspettare, di non trovare mai la giusta via di uscita, quando la porta della stanza 10 si apre e, istintivamente, il mio sguardo si solleva come quando ogni volta usciva un paziente e aspettavamo chiamassero il nostro numero. O come quando all’aeroporto lo aspettavo arrivare e alla fine il suo sorriso arrivava sempre. Mi sei mancata, Pan Pan.
A uscire da quella stanza di ambulatorio, questa volta, è un ragazzo alto, bello, avrà trenta, massimo trentatré anni. È vestito in giacca senza la cravatta, deve essersela tolta uscito dall’ufficio nella strada per venire qua. Le scarpe sono nere e pulite, i capelli corti e ben tagliati. Non ha il soprabito, anche se fuori l’aria inizia a farsi più fresca nonostante l’estate sembra essersi prolungata oltre qualche giorno. Oltre alle scarpe, la camicia bianca, le spalle larghe e il viso bello, quello che noto sono gli occhi, tesi, lesi, scavati dalla stanchezza e cavati da qualche notizia che non sapevi di aspettare. Quei tipici occhi di quando la mattina ti alzi e hai trent’anni e il mondo ti appare giusto e forse anche bello, e uscendo da una visita di controllo che non pensavi neanche fosse così importante, massì vedrai che è una ciste, vedi il sole sprofondare sotto la terra e la voce abbassarsi oltre un attimo di tenebra.
Subito dietro di lui esce anche una ragazza, alta il giusto, gambe snelle, capelli scuri e lisci che scendono dritti e ordinati oltre il trench beige. Tiene in mano, stretta davanti al petto e a sorreggere il cuore, una cartellina verde, e con delle falcate pesanti cerca di stare dietro a quello che credo sia il suo fidanzato o suo marito, come a uscire dalla sua pelle e provare ad abbracciarlo per un attimo con l’animo, vedrai che non è niente, a Natale riusciamo ad andare a sciare con i tuoi amici. Li seguo con lo sguardo e li vedo su un letto di ospedale, lui con il volto ancora bello ma gonfio dai farmaci, fa fatica a respirare e a parlare, così lei, seduta su una sedia scomoda da parte a lui, gli fa cenno di non affaticarsi mentre gli accarezza la mano per calmare più lei che lui e per dirgli di non andare, di non lasciarla lì da sola in quel brutto ospedale dalle pareti gialle, mentre sul viso ancora giovane si scava una profonda ruga che non se ne andrà mai via. Perché quando perdiamo noi stessi, tutto si perde, anche i lineamenti del volto, evaporati su strade senza fine.
Sbatto le palpebre e in quella frazione di secondo mi trovo nuovamente circondata da sedie di plastica e persone ferme ad aspettare. La luna ora è più netta, visibile anche a chi non ci ha mai fatto caso alla sua presenza lungo tutto questo giorno. Ciò che si vede non sempre è ciò che è.
Dalla stanza esce ora la dottoressa, si affaccia verso quella sala di aspetto e mi abbraccia con lo sguardo, invitandomi a seguirla con un cenno.
Entro, chiudo dietro la porta e quel brusio che non mi si toglie mai di dosso.
Passa più di un’ora quando la porta si riapre. Sulla soglia, prima di congedarmi, consegno alla dottoressa un piccolo pacchetto.
Questo è un libro di Stefano, lo ha letto qualche mese prima di morire. Parla di un ragazzo che a causa di un tumore non poteva più camminare e, nonostante l’handicap, ha imparato a girare il mondo. Mi farebbe piacere che lo tenesse lei, questo libro. Dentro trova anche una piccola dedica scritta da me e qualche nota sparsa di Stefano.
Allungo la mano e lei prende il libro dalle dita.
Sei una donna molto forte e coraggiosa, Charlotte. In tutti questi tanti anni, è la prima volta che mi capita che la compagna di un mio paziente mi scriva per vedermi e parlarmi e ringraziarmi. Di solito, quando la persona cara viene a mancare, non vedo più nessuno, perché nessuno vuole più tornare qui, dove il male che vuoi solo provare a dimenticare ha avuto origine. Mi dico sempre che faccio un lavoro brutto perché quasi nessuna delle persone che entra da questa porta uscirà guarita. Ad oggi non esiste una cura per il melanoma, ma il motivo per cui continuo ad amare questo lavoro è che provo a dare alle persone un motivo per continuare a vivere. E questa cosa ci tengo a dirtela davvero con il cuore, Charlotte: io non ho mai visto nessuno, nelle condizioni di Stefano, vivere così a lungo e questo è indice di quanta voglia avesse di vivere. E tu sicuramente sei il motivo per cui ha sempre creduto di voler vivere.
Abbasso lo sguardo per permettere alle palpebre di muoversi e spostare dietro le lacrime.
Sa, quello che lei dice io lo so e mi fa piacere sapere che non è solo frutto del mio amore per Stefano. Ma è anche vero che ho come la percezione, forse anche la presunzione, che se Stefano alla fine è morto sia in qualche modo colpa mia.
In che senso?
Credo che a un certo punto, semplicemente, abbia realizzato che non avrebbe mai vinto contro il tumore, per quanto ci abbia provato e abbia resistito così a lungo, e vedendo la mia stanchezza, è come se morendo avesse voluto lasciarmi libera. Solo che io mi sono trovata imprigionata in un tunnel buio e stretto che non sembra avere mai fine. E darei la mia vita e tutta me stessa per riavere lui e quella meravigliosa stanchezza.
Penso che tu abbia ragione, Charlotte. Ma quello che Stefano ha voluto regalarti con il suo gesto è il tempo. E tu devi prenderti cura di questo tempo e di tutto il tempo che avete avuto insieme. E sono certa che lo farai. Se oggi sei qui è perché vuoi farlo.
La guardo negli occhi e poi fuori dalla finestra e un senso di breve pienezza attraversa parti del mio corpo che credevo dimenticate.
Ciao Charlotte. Buona vita, saprà ancora esserti bella.
Ci abbracciamo e mi giro per imboccare quel corridoio che mi ha condotto fin qua quando, all’improvviso, mi volto di nuovo.
Dottoressa…
Sì?
Quei due ragazzi che c’erano prima di me…ce la faranno?
Mi guarda come si guardano i bambini che chiedono qualcosa di infinitamente dolce che mai succederà.
Gli darò tutto il tempo di cui avranno bisogno.
Varco la soglia automatica dell’ingresso ed entro in un vortice di aria fresca, lasciandomi alle spalle il peso della giornata e l’intensità dei suoi momenti. Il giorno è ormai buio e nel cielo risplende qualche stella. Il bar dall’odore vecchio ha già abbassato la saracinesca, mentre il fruttivendolo sta ritirando le ultime casse prima della chiusura.
Raggiungo la macchina, passando davanti a quel posto dove avevamo parcheggiato l’ultima volta e lo vedo che si accende una sigaretta prima di salire in macchina.
Mentre lo aspetto, nella mente si tracciano i volti morbidi di quei due ragazzi, ora in casa alla fine di quella giornata che parlano al telefono con i genitori, si abbracciano e mangiano un piatto di pasta dopo aver fatto la doccia. Probabilmente, stasera non faranno l’amore, ma se avranno quel giusto tempo impareranno a trovare nuovi contorni dentro il caleidoscopio imprevedibile che è l’amore.
Salgo in macchina, accendo la musica e torno verso casa. Sulla strada, lungo le vie buie che mi appaiono inesplorate, la luna è alta, il cielo sereno e la vita inspiegabilmente bella perché quando muori, la morte è come se scomparisse, come se uscisse di scena, non esiste più perché non hai più paura di lei. E allora ti resta solo la vita dentro un mare infinto di onde di colore, dove l’inizio riprende sempre dalla fine. E dove tu non riesci a fare altro che continuare a guidare.
Photo: Una foto scattata sulla spiaggia di Coronado Beach, durante un viaggio in California nel 2017.
By Your Side resta in pausa ancora un po’.
Ma il suo mondo è sempre aperto a chiunque abbia voglia di qualcosa di bello.
Qui puoi leggere cosa è successo dopo questa giornata:
Se vuoi far conoscere questo libro a qualche amico, conoscente, parente, puoi regalarlo cliccando qui:
Se invece hai voglia di rileggere questa storia molto vera e spesso magica, puoi sfogliare i vecchi capitoli cliccando qui:
Io, su Instagram | I racconti precedenti
Copyright © 2024 By Your Side